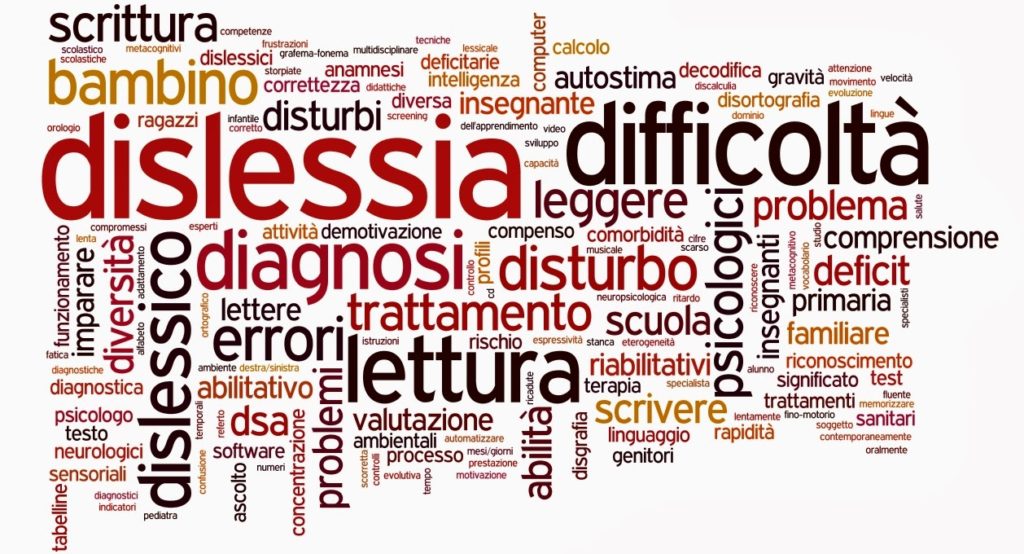
Innanzitutto, cosa sono i DSA?
In psicologia cognitiva, DSA è l’acronimo dei disturbi specifici dell’apprendimento, cioè i disturbi che colpiscono selettivamente i domini necessari per imparare.1
Quanti disturbi specifici dell’apprendimento esistono?
I disturbi specifici dell’apprendimento comprendono:
- dislessia – il disturbo della lettura;
- disgrafia – il disturbo grafomotorio della scrittura;
- disortografia – il disturbo linguistico della scrittura;
- discalculia – il disturbo del calcolo.
Vediamoli in dettaglio uno per uno!
1) Dislessia: il disturbo della lettura
La dislessia è il DSA più comune, tanto da essere usata – erroneamente – per identificare l’intera categoria. I dislessici hanno una lettura più lenta e/o meno accurata, rispetto a quanto ci si aspetterebbe in base all’età, alla classe e all’istruzione ricevuta.
Possono avere difficoltà a leggere le lettere, parole e non-parole (parole non esistenti) o interi brani in base all’età. A tal proposito, è emblematico il caso dell’attrice Jennifer Aniston, che ha scoperto il suo DSA da adulta:
“Pensavo di non essere intelligente, non riuscivo a trattenere niente. Per me è stata una grande scoperta, perché è come se molti dei miei traumi e dei miei drammi infantili avessero finalmente trovato una spiegazione.
Mi hanno messo un computer davanti, mostrandomi dove andavano i miei occhi mentre leggevo. La mia vista saltava quattro parole, poi tornava indietro di due (…)
Mi hanno fatto indossare un paio di occhiali con una lente blu e una rossa, e dovevo leggere un breve paragrafo per poi rispondere a dieci domande su quello che avevo appena letto. Penso di aver risposto bene solo a tre quesiti” (estratto dell’intervista all’Huffington Post).

2) Disgrafia: il disturbo grafomotorio della scrittura
La disgrafia colpisce le abilità manuali di scrittura, perciò la grafia risulta meno fluente e comprensibile.
3) Disortografia: il disturbo linguistico della scrittura
La disortografia complica la trascrizione corretta di parole, non-parole, frasi e testi che risultano zeppi di errori.
4) Discalculia: il disturbo del calcolo
La discalculia rende difficile riconoscere e distinguere i numeri, memorizzare i procedimenti e fare di conto.
Perché si sviluppano i DSA?
Arrivati a questo punto bisogna precisare che i DSA non sono malattie: secondo l’ipotesi neurobiologica, la più accreditata al momento, si tratta di atipie del neurosviluppo: in parole povere, in caso di DSA i neuroni coinvolti nella lettura, nella scrittura e/o nel calcolo, funzionano diversamente; ciò comporta anche diverse modalità di apprendimento.
I DSA possono presentarsi singolarmente, sovrapposti tra loro o ad altri disturbi, quali:
- disprassia (un disturbo dell’organizzazione dei movimenti);
- ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività);
- disturbi del comportamento e dell’umore.
Secondo i dati diffusi dal MIUR, 276.109 studenti italiani – il 3,2% del totale – hanno ricevuto una diagnosi di DSA. Il disturbo dell’apprendimento più comune è la dislessia, seguita da disortografia, discalculia e disgrafia.2
Come riconoscere i disturbi specifici dell’apprendimento?
Sebbene alcuni segnali in età prescolare (come il ritardo nel linguaggio) possano farci sospettare di DSA, la diagnosi conclamata avviene:
- non prima della fine della 2° elementare per dislessia, disgrafia e disortografia;
- non prima della fine della 3° elementare per la discalculia.
Alla scuola spetta il compito d’individuare, tenendo conto delle eventuali segnalazioni dei genitori, i casi sospetti di DSA, in modo che si possano fare i test diagnostici ed elaborare il piano didattico personalizzato (PDP) in caso di positività.
Di seguito elenchiamo gli errori più comuni che dovrebbero far sospettare un DSA:
- inversione di lettere e/o numeri (lad al posto di dal, 14 al posto di 41);
- sostituzione di lettere graficamente simili (m/n, b/d, a/e);
- difficoltà ad apprendere le informazioni in sequenza (alfabeto, giorni, mesi, tabelline);
- confusione dei rapporti spazio-temporali (destra-sinistra, ieri-domani);
- difficoltà nelle abilità motorie (non riescono ad allacciarsi le scarpe).
Questi segnali, se presenti alla fine della II o III elementare, richiedono la visita specialistica presso l’ASL di riferimento o privati. In caso di effettiva diagnosi, lo studente dovrà imparare a convivere col disturbo – anche e soprattutto grazie alla scuola.
Come convivere con i DSA?
La legge n. 170/2010 sancisce la tutela del diritto allo studio degli studenti con DSA, attraverso le strategie e gli strumenti compensativi che rendono meno difficoltoso l’apprendimento.3 Vediamoli!
1) Strategie compensative
Gli indici testuali aiutano a trattenere le informazioni durante lo studio, migliorando la memoria di lavoro e dunque l’apprendimento.
Gli indici testuali sono:
- immagini con didascalie;
- titoli e sottotitoli;
- parole chiave in grassetto;
- box con approfondimenti;
- box col significato di particolari termini;
- mappe concettuali;
- schemi e tabelle;
- fumetti.
Usandoli, lo studente riuscirà ad avere una visione d’insieme del testo e sarà incoraggiato ad approfondirlo.
2) Strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi consentono allo studente di apprendere meglio e con minore sforzo, ma attenzione: non privilegiano lo studente con DSA, esattamente come gli occhiali non aiutano a vedere meglio degli altri; gli permettono solo di stare allo stesso livello dei compagni.
Tra gli strumenti compensativi più importanti, vi sono il computer e i suoi software:
- sintesi vocale, che converte il testo digitale in audio ed è pertanto utile in caso di dislessia;
- editor di testi, dotato di correttore ortografico e sintesi vocale, permette di usare gli indici testuali, risultando utile nei dislessici e disgrafici;
- riconoscitore vocale, che converte le parole pronunciate al microfono in testo senza la tastiera, perciò è importante nelle forme gravi di disgrafia;
- internet – serve per cercare informazioni, tradurre testi in lingua straniera e accedere ai contenuti multimediali, di particolare importanza per i dislessici; ad esempio, sul canale Divina Commedia HD è possibile studiare l’opera del sommo Dante grazie a dei bellissimi video.
Prima di salutarci, vi lasciamo con una chicca!
Personaggi famosi con un DSA
A riprova del fatto che i DSA non sono un limite ai propri obiettivi, di seguito vi forniamo un elenco dei personaggi famosi con questi disturbi:
- Jennifer Aniston;
- Tom Cruise;
- Harrison Ford;
- Dustin Hoffman;
- Whoopi Goldberg;
- Robin Williams;
- Mozart;
- Beethoven;
- Cher;
- John Lennon;
- Robbie Williams;
- Michelangelo;
- Raffaello;
- Van Gogh;
- Picasso;
- Andy Warhol;
- Leonardo da Vinci;
- Isaac Newton;
- Albert Einstein;
- Galileo Galilei;
- Charles Darwin;
- Jacques Dubochet, il premio Nobel per la Chimica 2017.
Consigli di lettura
Se l’articolo vi è piaciuto, leggete anche quello dedicato alla sintesi vocale con JavaScript.
Riferimenti bibliografici:
- sito dell’Associazione italiana dislessia (AID);
- dati del MIUR (2017/2018);
- legge 170/2010.
L’articolo ha uno scopo puramente illustrativo e non sostituisce il rapporto medico-paziente.

Blogger e giornalista, ho collaborato con L’Unione Sarda.
Sono cofondatrice e curatrice editoriale di Inchiostro Virtuale.
Per contattarmi, inviate una mail a: j.zanza@inchiostrovirtuale.it




